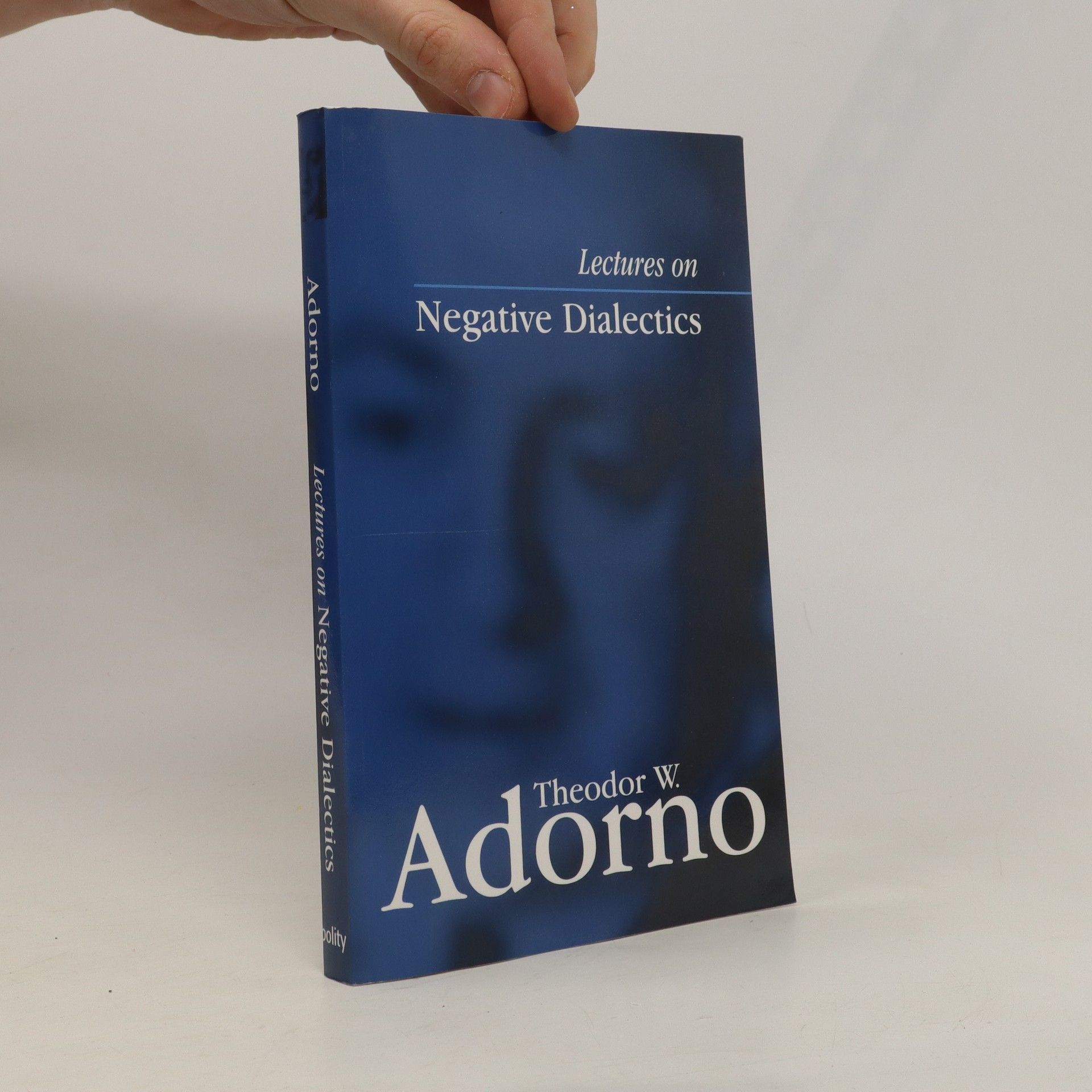Theodor W. Adorno Libri
Theodor W. Adorno emerse come un filosofo e critico sociale tedesco fondamentale nell'era post-Seconda Guerra Mondiale. La sua influenza affonda le radici nella natura interdisciplinare della sua ricerca e nella sua appartenenza alla Scuola di Francoforte. Esaminò rigorosamente le tradizioni filosofiche occidentali e offrì una critica radicale della società occidentale contemporanea. Inizialmente ostacolata da traduzioni inaffidabili, l'opera di Adorno ha visto una rinascita nei paesi di lingua inglese, con traduzioni migliorate e pubblicazioni postume che ne consolidano l'impatto sull'epistemologia, l'etica, l'estetica e la teoria culturale.






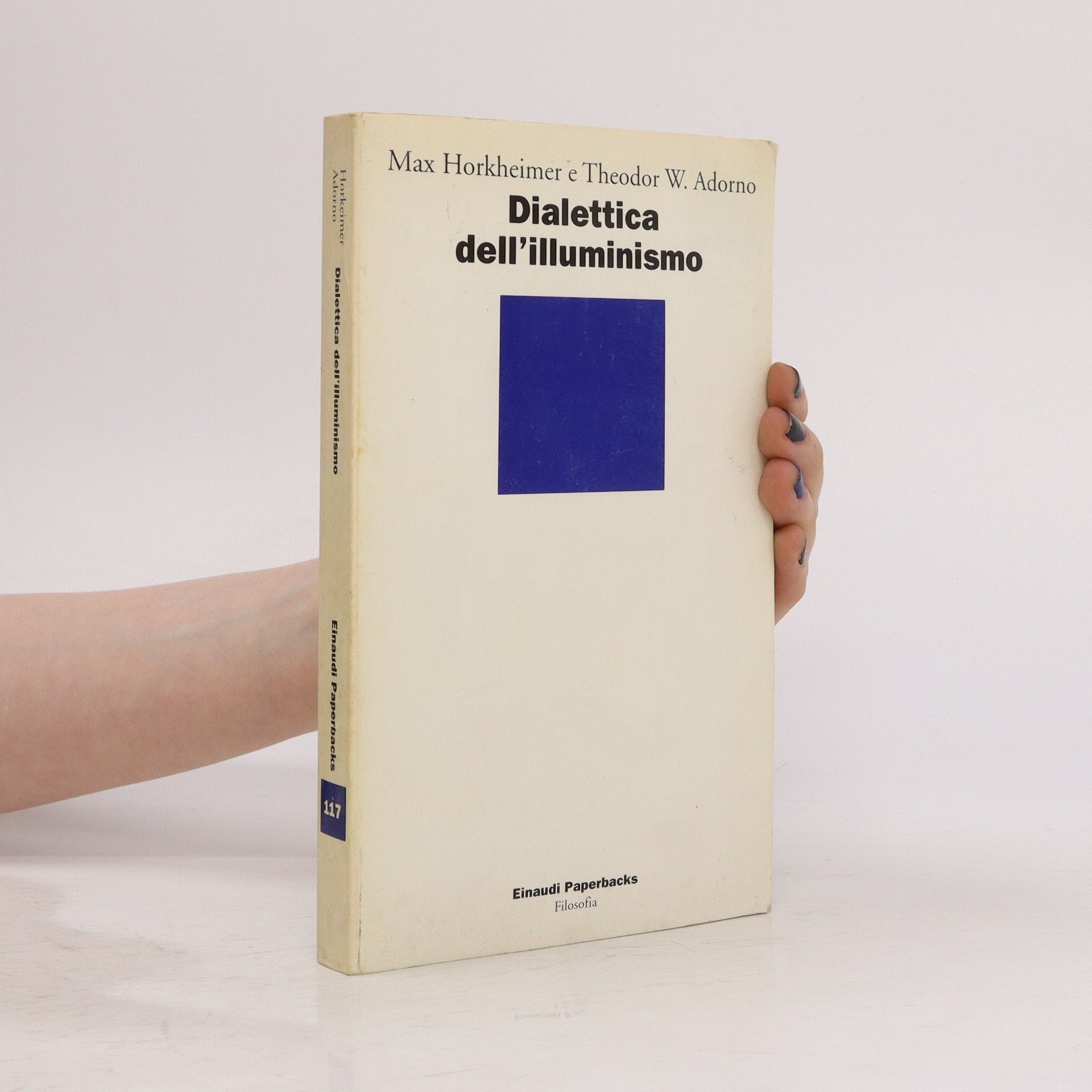
Introduzione alla sociologia della musica
- 283pagine
- 10 ore di lettura
'La musica - scrive Adorno - non è ideologia tout court, ma è ideologia nella misura in cui è falsa coscienza. Di conseguenza la sociologia musicale dovrebbe prendere le mosse dalle incrinature e dalle fratture dell'accadimento musicale nel momento in cui queste non sono da imputare esclusivamente all'insufficienza soggettiva di un singolo compositore'. I capitoli sono dedicati ai tipi del comportamento musicale; alla musica leggera, opera lirica, musica da camera; alle funzioni della musica; alle classi e agli strati sociali; ai rapporti tra direttore e orchestra; ai modi della vita musicale; ai rapporti tra opinione pubblica e critica; al nazionalismo musicale; alla musica moderna.
History and freedom
- 368pagine
- 13 ore di lettura
"Early in the 1960s Adorno gave four courses of lectures on the road leading to Negative Dialectics, his magnum opus of 1966. The second of these was concerned with the topics of history and freedom. In terms of content, these lectures represented an early version of the chapters in Negative Dialectics devoted to Kant and Hegel. In formal terms, these were improvised lectures that permit us to glimpse a philosophical work in progress." -- Cover, p. [4].
Notes to Literature
- 560pagine
- 20 ore di lettura
Notes to Literature is a collection of the great social theorist Theodor W. Adorno's essays on such writers as Mann, Bloch, Goethe, and Benjamin, as well as his reflections on a variety of subjects. This edition presents this classic work in full in a single volume, with a new introduction by Paul Kottman.
Philosophical Elements of a Theory of Society
- 192pagine
- 7 ore di lettura
First published in German as Philosophische Elemente einer Theorie Der Gesellschaft, 1964.
Two volumes by Theodor W. Adorno are combined in this volume: Interventions - Nine Critical Models (1963) and Catchwords: Critical Model II (1969). Both books are examples of Adorno's postwar commitment to unmasking the culture that engendered Nazism.
Philosophy and Sociology: 1960
- 320pagine
- 12 ore di lettura
In summer 1960, Adorno gave the first of a series of lectures devoted to the relation between sociology and philosophy. One of his central concerns was to dispel the notion, erroneous in his view, that these were two incompatible disciplines, radically opposed in their methods and aims, a notion that was shared by many. While some sociologists were inclined to dismiss philosophy as obsolete and incapable of dealing with the pressing social problems of our time, many philosophers, influenced by Kant, believed that philosophical reflection must remain ‘pure’, investigating the constitution of knowledge and experience without reference to any real or material factors. By focusing on the problem of truth, Adorno seeks to show that philosophy and sociology share much more in common than many of their practitioners are inclined to assume. Drawing on intellectual history, Adorno demonstrates the connection between truth and social context, arguing that there is no truth that cannot be manipulated by ideology and no theorem that can be wholly detached from social and historical considerations. This systematic account on the interconnectedness of philosophy and sociology makes these lectures a timeless reflection on the nature of these disciplines and an excellent introduction to critical theory, the sociological content of which is here outlined in detail by Adorno for the first time.
This volume features key lectures leading to Adorno's 1966 work, Negative Dialectics, focusing on essential concepts from its introductory section. It showcases Adorno as a philosopher navigating his methodology amidst contemporary trends. As a critical theorist, he rejects outdated Marxist stereotypes prevalent in the Soviet bloc, addressing students who fled East before the Berlin Wall's construction in 1961. While influenced by empirical thought from the U.S., he resists its tendency toward scientific abstraction, avoiding a return to traditional idealisms in Germany or the new ontology of Heidegger and his followers. Adorno seeks to articulate a 'negative', critical approach to philosophy, emphasizing the pervasive power of totalizing systems in the post-Auschwitz world. His intellectual negativity leads to a steadfast defense of individuals—both facts and people—who resist integration into 'the administered world.' The lectures reveal Adorno as an engaging speaker, demanding yet lively, interspersing his arguments with insights on philosophers and writers like Proust and Brecht, alongside reflections on current events. This blend of rigorous intellectual discourse and concern for student engagement characterizes his teaching style.
Kant's Critique of Pure Reason
- 300pagine
- 11 ore di lettura
Adorno's exploration of Kant's "Critique of Pure Reason" reveals the significant influence Kant has on his philosophical framework. This volume compiles Adorno's lectures, offering insights into Kant's critical philosophy and its implications for modern thought. Through these discussions, Adorno engages deeply with Kant's ideas, shedding light on their relevance and impact on subsequent philosophical discourse.
Minima Moralia. Reflections From Damaged Life
- 268pagine
- 10 ore di lettura
'Radical Thinkers' is a selection of Verso's leading titles, celebrating 40 years of New Left Books and Verso. The volumes collected here are new editions of the highlights from 4 decades of uncompromising, radical publishing.